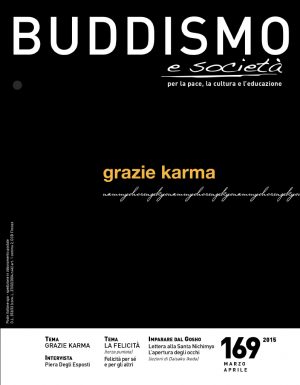di Monica Piccini
Ancella di Maria Callas nella Medea di Pierpaolo Pasolini («”Mi piace la tua faccia perché non hai un volto d’attrice”, mi disse lui e io me la presi»), madre di Nanni Moretti in Sogni d’oro, segretaria di Giulio Andreotti nel Divo di Paolo Sorrentino («Io e Servillo ci guardavamo trasfigurati: “Siamo davvero entrati nella Democrazia cristiana”»), generosa governante massacrata dagli eventi nella Sconosciuta di Giuseppe Tornatore («Non m’importava imbruttirmi, avevo l’obiettivo di far parlare il mio talento»), zia cinica in L’ora di religione di Marco Bellocchio, avvocata divorzista autoritaria e sempre pronta a ridicolizzare gli altri in Tutti pazzi per amore di Riccardo Milani…
Nonostante mille ruoli che hanno fatto la loro storia in teatro, al cinema e poi in tv, come attrice non hai mai lasciato la tua vita in camerino. Anzi, l’hai raccontata nel libro Storia di Piera, scritto a quattro mani con Dacia Maraini nel 1980. Che cosa ti ha spinto a condividere la tua storia scandalosa?
Volevo vendicare mia madre (il libro racconta di una madre bipolare, divisa fra sonno invernale e scorribande erotiche estive in cui coinvolgeva anche la figlia, n.d.r.) che per i suoi comportamenti è stata naturalmente molto criticata e condannata a scontare i suoi peccati con gli elettroshock. In quelle pagine ho voluto raccontare che regalo è stato per me il suo modo di vivere. Mi ha insegnato l’amore per gli altri, a godere della vita come se ogni giornata contenesse una sorpresa. Certo, errori ne ha commessi, considerandomi non una figlia bensì un’amica, persino una compagna di avventure amorose. Non ha tenuto conto della mia fragilità di adolescente (provavo rabbia, vergogna), per non parlare delle sofferenze procurate a mio padre, comunque innamorato di lei. Ciò nonostante, ha fatto il suo dovere di madre. Perché se, a dispetto dei traumi, ho sempre sentito l’urgenza di conquistare un pezzetto di felicità tutti i giorni, ecco questo è la prova della sua generosità. Non avrei mai scritto di lei se non fosse stata d’accordo. E siccome glielo chiesi in estate, nel suo periodo di esaltazione, lei disse: «Va benissimo, io sono una madre astratta». Intendeva dire, fuori dai canoni. E noi, con Dacia, procedemmo, finché quando il libro uscì – era inverno a quel punto – mia madre rimase spiazzata davanti alle infermiere della clinica psichiatrica, dov’era ricoverata, che l’apostrofavano dicendo: «Ammazza, sei stata una bella gaglioffa!». Non capiva a cosa alludessero.
Quando parli di tua madre viene in mente il Gosho di Capodanno in cui Nichiren scrive: «L’inferno è nel cuore di chi interiormente disprezza suo padre e trascura sua madre».
Mia madre mi ha insegnato anche un grande senso di avventura, nonostante le mie paure che scappasse di notte. Le davo i sonniferi che mi avevano raccomandato i dottori, perché temevo cadesse. Per starle dietro non ho proseguito la scuola, ma non l’ho mai vissuta come una mancanza, anzi. Mi sentivo il suo pilastro. Anche perché mio padre fu trasferito dal partito (comunista) in Veneto, per condotta scandalosa della moglie. Con lei quindi rimasi io, la capofamiglia quattordicenne, e mio fratello, un bambino di dieci anni. Mia sorella Carla, alla quale sono stata legatissima, già frequentava la scuola del Cremlino, selezionata da Togliatti in persona. Entrambi i miei genitori sono stati molto contenti che facessi l’attrice, con mia grande gioia. Mi consideravano una persona un po’ speciale. Mia madre mi diceva spesso: «Chi ti conosce non ti dimentica», e questo mi ha dato una grande forza crescendo. La mia forza è stata avere due genitori così, nonostante fossero dilaniati dai problemi.
La parte “costruttiva” del karma consiste nell’adoperare ciò che ci accade nella vita per ispirare altre persone. Tu è come se fossi stata buddista prima ancora di diventarlo. Non hai mai avuto paura del giudizio degli altri?
Mia madre potevo giudicarla io, non gli altri. Quanto a me, fare l’attrice, “abitando” sempre personaggi diversi da me stessa, è stato un modo per esorcizzare questa paura. Il pubblico ti giudica, è vero, ma non per quello che sei intimamente tu.
Nel 2007, anno in cui hai cominciato a praticare (a settant’anni), alla Festa del Cinema di Roma eri l’attrice più presente sugli schermi. È cambiata la tua vita da quando reciti Nam-myoho-renge-kyo?
Sì, è cambiata. In passato sono stata molti anni in psicanalisi, in verità mai senza un supporto psicologico. Dopo aver sperimentato la pratica buddista ho detto al mio psicanalista, che ha capito: «Non vengo più perché mi sembra che quella spinta che ricevo da lei ora la trovo nel Buddismo, e mi sento di fare una sola cosa alla volta».
Ho avuto fin da subito un rapporto appassionato con quest’insegnamento. Volevo leggere quanti più libri possibile e avere subito il Gohonzon in casa. Per praticare andavo da chi già lo aveva, senza cercare troppe spiegazioni, confondendo il karma con gli altri principi fondamentali. Volevo far parte di questi suoni, la recitazione del Daimoku. Ho agito così, incoraggiata dal fatto che Nichiren fosse povero, con una forza questo ragazzino, figlio di pescatori di alghe, così come lo erano anche i genitori del presidente Ikeda. Di Ikeda, poi, mi ha molto colpito che avesse la tubercolosi, una fragilità polmonare di cui soffro anch’io. Nel ’77 mi hanno tolto le pleure, e per un’attrice recitare senza pleure è come per un ciclista avere problemi alle gambe. In questo la lettura del Diario giovanile (in cui Ikeda racconta delle sue difficoltà di salute e del freddo che pativa) mi ha molto aiutato e confortato. Ho cominciato a vedere l’impronta del Buddismo su di me quando a partire da un carattere brontolone sono diventata una donna capace di vedere il bicchiere mezzo pieno.
Uno dei cambiamenti più grandi, inoltre, ha riguardato la pigrizia: adesso uso l’azione anche quando mi viene una lieve depressione che non mi spiego. Come se l’azione sorprendente, che addirittura non mi ricordo di aver compiuto e già l’ho fatta, fosse uno dei miei miracoli quotidiani. Per cui, direi che la cosa più impressionante, nel Buddismo, è il cambiamento della persona. Non è che sia diventata questa meraviglia, però certamente sono cambiata, nonostante gli alti e bassi della vita. Non sempre, infatti, pratico nello stesso modo: ci sono momenti che non posso andare alle riunioni, momenti che ho meno fiato, in cui mi dico «non importa, vai anche solo a salutare». Ecco questo va bene. Quello che non va bene è la paura. E sulla paura, diciamo, le parole di Nichiren non mi hanno ancora portato a trasformare questo stato d’animo. Bisogna tener conto che non ho mai accettato il fatto di essere mortale, perché ho sempre pensato che la morte prende uno spazio che non le compete. Vale a dire, la vita è corta, è densa, è felice, è quello che è, ma non è tanto lunga. Invece la morte ha l’eternità a disposizione, per cui non deve venire a disturbare quel poco spazio di cui dispone la vita. Finché uno è vivo sta nella vita, purtroppo questo è più difficile quando diventi una persona anziana. Anche in questo mia madre è stata un esempio. Fino all’ultimo era viva, e guardava sfacciatissima un infermiere che invece non aveva occhi che per un’infermiera lì vicino. Tornando al Buddismo, mi sembra di essere diventata abbastanza brava, tranne che per la paura e l’accettazione della morte.
Conosci il modo di dire “pimpin colorì” delle persone anziane che in Giappone praticano da molti anni? Vuol dire “vivere pimpanti fino all’ultimo e morire senza accorgersene”. Significa che non ci si deve preparare alla morte: la morte si prepara con la vita.
Questo è vero. Quando infatti mi viene paura della malattia o della fine fisica passo alle vie di fatto, chiamo per esempio le persone che penso stiano soffrendo, sto vicino a chi è in difficoltà. Se non avessi fatto l’attrice avrei fatto l’infermiera, ma avevo paura del sangue, l’infermiera dell’anima.
Scegliere il proprio karma appropriato, secondo il Buddismo di Nichiren, significa affrontare una sfida e vincere per incoraggiare altre persone in una battaglia simile. Questa della paura è una delle tue tante sfide, come quando a inizio carriera non riuscivi a superare i provini. A questo proposito, da aspirante attrice bocciata all’Accademia d´Arte Drammatica a protagonista di un bel documentario (Tutte le storie di Piera di Peter Marcias) sulla tua parabola d’artista che abbraccia le generazioni, che cosa consiglieresti ai giovani e al loro desiderio di realizzazione?
Ai giovani direi che se vogliono riuscire in qualcosa devono fare gli allenamenti. Io credo all’ossessione di una passione. Bisogna avere un pensiero fisso su ciò che si desidera, sia un record sportivo o una carriera artistica. Quando si vuol realizzare qualcosa non c’è tutto questo tempo, perché bisogna tener conto che nella vita ci sono anche gli avversari. All’inizio per dieci anni come attrice non mi ha scelto nessuno. Ma non ho mai mollato perché pensavo di avere talento. Nonostante i problemi familiari tutti i giorni facevo qualcosa per estrarre queste mie capacità da me stessa. Gli ho creduto a questo mio talento e di conseguenza mi sono battuta per lui anche contro tutte le critiche. I premi degli ultimi tempi in realtà premiano la mia grande ossessione.
Nell’Enciclopedia Treccani alla voce “Degli Esposti, Piera” si legge: «Attrice italiana (n. Bologna 1939). Dotata di forte personalità e di una sensibilità esasperata, all’origine di uno stile interpretativo viscerale…». L’ultimo premio, per il teatro, risale al dicembre scorso, nell’ambito della 44ma Giornata d’Europa, in Campidoglio a Roma. Il 26 gennaio 2015 la presentazione, al Piccolo Teatro di Milano, dell’ultimo libro che parla di lei (Bravo lo stesso! Il teatro di Piera Degli Esposti di Manuel Giliberti, Lombardi editore). E in mezzo più di cinquant’anni di passione e recitazione. Respinta (forse per via del suo modo “aeroplanistico” di muoversi) dall’Accademia d’Arte Drammatica, alla fine degli anni Sessanta esordisce a Roma con il Teatro dei 101, diretto da Antonio Calenda, per poi recitare in Antonio e Cleopatra al Teatro Stabile dell’Aquila e allo Stabile di Firenze. È del 1979 lo spettacolo teatrale che fa conoscere il suo grande talento interpretativo, con il monologo Molly cara, tratto dall’Ulisse di Joyce per la regia di Ida Bassignano. In camerino Eduardo De Filippo la definì «o’ verbo nuovo». Il 1967 segna l’inizio della sua lunga carriera cinematografica. Primo film: Trio diretto da Gianfranco Mingozzi. Seguiranno Questi fantasmi di Renato Castellani, Medea di Pier Paolo Pasolini e Sotto il segno dello scorpione dei fratelli Taviani. A teatro lavora con registi del calibro di Scaparro, Guicciardini, Sequi e Castri conquistando consensi con Madre Coraggio, Prometeo e lo Stabat Mater. Nel 1986 interpreta Teresa in La coda del diavolo dell’esordiente Giorgio Treves e conquista il Nastro d’Argento. Lina Wertmuller la dirige in Scherzo del destino in agguato dietro l’angolo come un brigante di strada (1983), Il decimo clandestino (1989) e Metalmeccanico e parrucchiera in un turbine di sesso e di politica (1996). Miglior attrice non protagonista: nel 2003 con L’ora di religione di Marco Bellocchio e nel 2009 con Il Divo di Paolo Sorrentino. Nel 2010 è diretta da Veronesi in Genitori e figli: agitare bene prima dell’uso e lavora nella fiction Rai Tutti pazzi per amore.
La sua più recente interpretazione è nel film Cloro, opera prima di Lamberto Sanfelice, presentato in anteprima mondiale al Sundace Film Festival, e selezionato per la sessantacinquesima edizione della Berlinale (dal 5 al 15 febbraio 2015).